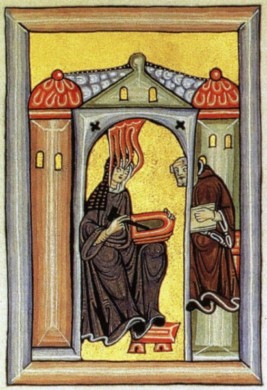La polvere alcolica, nota anche come alcool in polvere o alcool secco, rappresenta una delle innovazioni più controverse e affascinanti del panorama delle bevande alcoliche contemporanee. Si tratta di una sostanza in polvere che diventa bevanda alcolica quando viene miscelata con acqua, ottenuta tramite un complesso processo chiamato microincapsulamento, che racchiude l’etanolo in piccole capsule solubili. Questa scoperta, che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ha radici che risalgono agli anni Sessanta in Giappone e continua a generare dibattiti su sicurezza, regolamentazione e impatto sociale.
L’invenzione risale al 1966, quando la Sato Foods Industries, un produttore giapponese di additivi alimentari, sviluppò la tecnica della polverizzazione dell’alcol. Solo l’anno successivo iniziò la produzione e la vendita di alcol in polvere ad alto contenuto, con il marchio “Alcock”. Nel 1974, Sato brevettò un processo pratico di produzione, estendendo la protezione in diciassette paesi. Negli anni Settanta, l’azienda iniziò a promuovere il prodotto anche negli Stati Uniti, con una vendita di prova denominata “SureShot”. Parallelamente, in Turchia, nel 1973, un chimico sviluppò una versione in polvere del rakı, il tradizionale liquore all’anice, anticipando l’interesse globale per queste bevande innovative.
Il processo chimico alla base della polvere alcolica è affascinante: la bevanda alcolica viene combinata con un carboidrato solubile in acqua, tipicamente maltodestrina, e quindi essiccata a spruzzo. Questo metodo produce microcapsule in cui l’acqua evapora più rapidamente dell’etanolo, creando una polvere stabile e facilmente trasportabile. Il prodotto finale può contenere oltre il 30% di alcol in volume allo stato di polvere, rendendolo potente quanto una bevanda liquida tradizionale.
Nonostante la praticità, l’alcol in polvere non è esente da controversie. Esperti di salute pubblica hanno espresso preoccupazioni riguardo a potenziali abusi: la polvere è facilmente trasportabile, discreta e può essere somministrata in modi nuovi e rischiosi, aumentando il rischio di sovradosaggio e danni legati all’alcol. Negli Stati Uniti, l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau approvò nel 2015 quattro prodotti Palcohol, ma la distribuzione è stata soggetta a divieti e regolamentazioni statali, in risposta a timori su uso improprio da parte di minori e sicurezza pubblica. Ad oggi, la maggior parte degli stati mantiene restrizioni severe, mentre solo pochi hanno legalizzato la vendita.
A livello globale, lo status legale della polvere alcolica varia notevolmente. In Giappone è classificata come bevanda alcolica dal 1981, mentre in Australia, Germania, Paesi Bassi e Russia sono state adottate norme restrittive o vieti parziali. Nel Regno Unito, la polvere alcolica resta in una zona grigia: non è espressamente vietata, ma non esiste una regolamentazione chiara sul commercio e sul consumo.
Oltre agli aspetti legali e sanitari, la polvere alcolica ha stimolato anche curiosità gastronomica. Chef e bartender hanno sperimentato cocktail asciutti e drink ricostituiti, aprendo la strada a creazioni innovative come martini secchi o bevande frizzanti aromatizzate, con il vantaggio di trasportabilità e lunga conservazione. Tuttavia, la polvere alcolica rimane principalmente di nicchia, utilizzata in ambiti controllati e più come esperimento culinario che come sostituto quotidiano delle bevande liquide.
L’alcol in polvere rappresenta un esempio emblematico di come innovazione e regolamentazione si incontrino nel mondo delle bevande alcoliche. È un prodotto che sfida la tradizione, ma richiede cautela, conoscenza e rispetto delle normative. Ogni bustina di polvere non è solo una curiosità tecnologica, ma anche un invito a riflettere su consumo responsabile, sicurezza pubblica e i confini tra innovazione e salute.